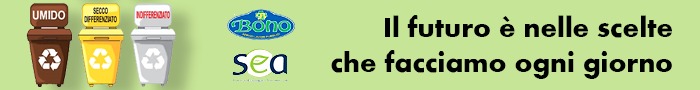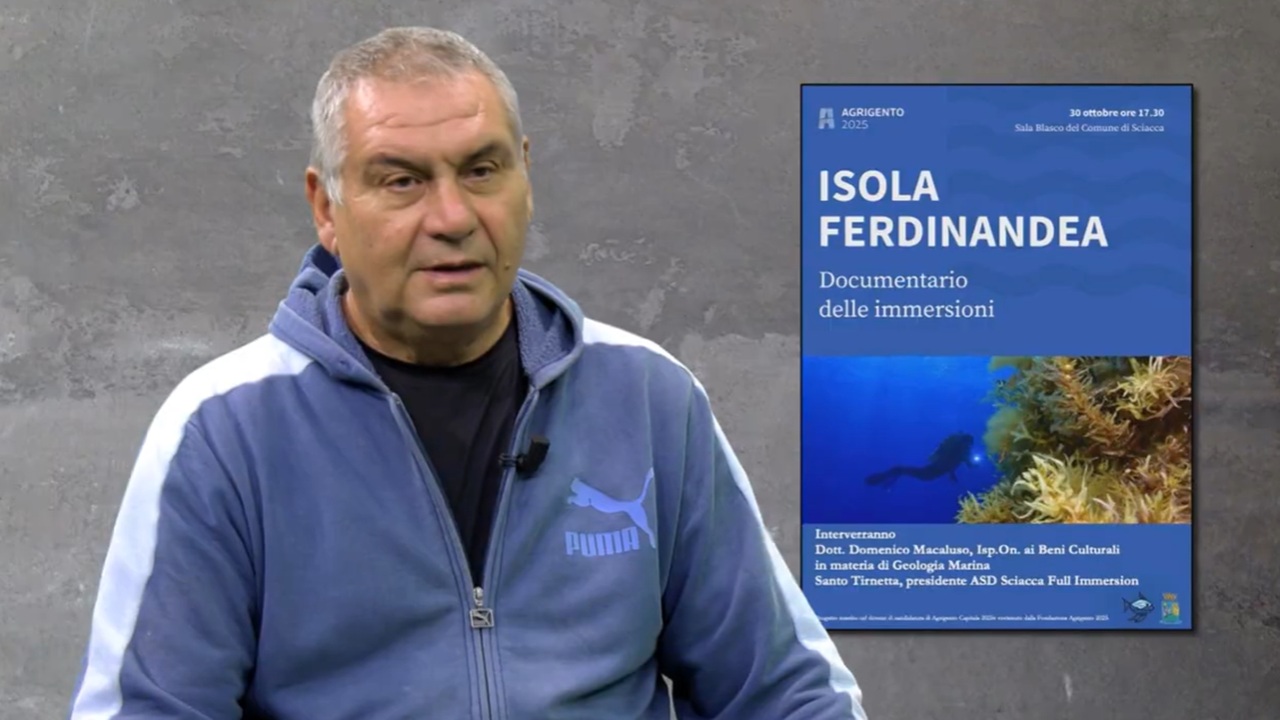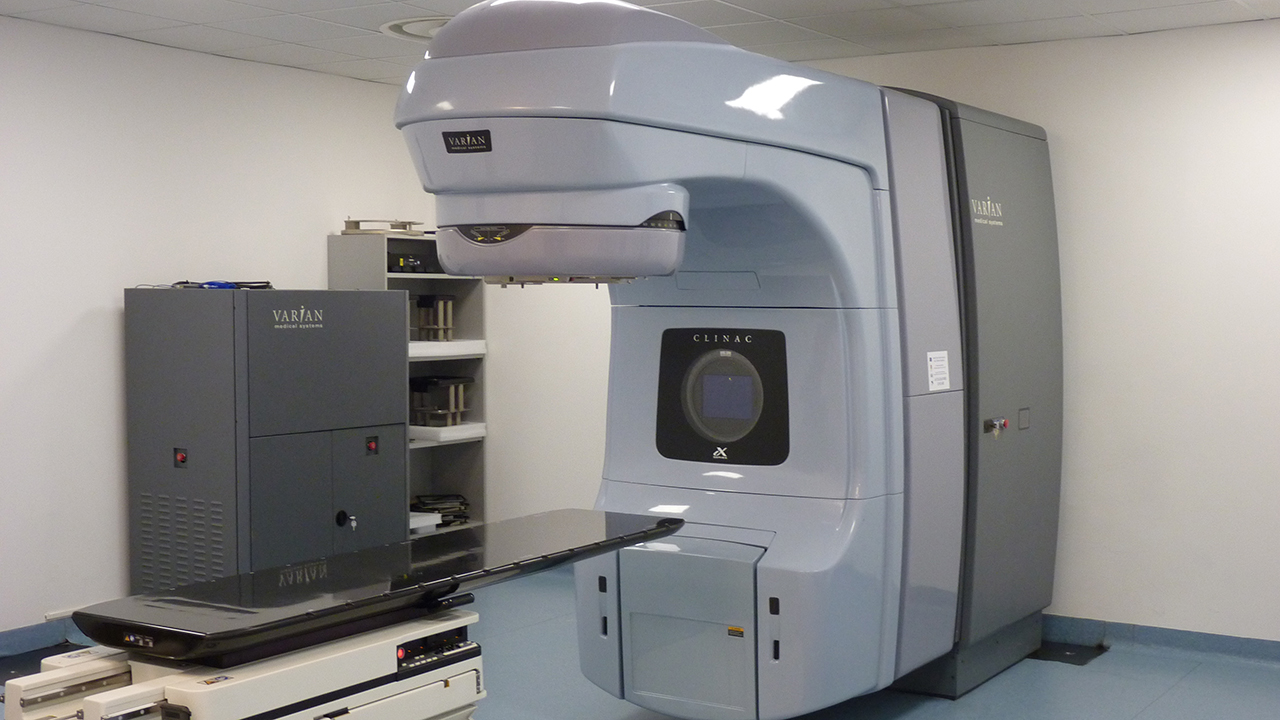La lectio magistralis di Massimo Cacciari ad Agrigento

“Riaffermiamo il valore del pensiero filosofico contro l’intelligenza artificiale”
Davanti ad un teatro Pirandello di Agrigento pieno in ogni ordine di posto, la lectio magistralis di Massimo Cacciari ha aperto ufficialmente la quattro giorni di “Sphairos – incontri filosofici nei luoghi di Empedocle”, parte del programma ufficiale di Agrigento Capitale italiana della Cultura sul tema “Dentro e fuori dalla caverna di Platone”. Cacciari, intervenuto dopo i saluti istituzionali e l’intervento dell’archeologa Maria Concetta Parello su “I luoghi di Empedocle” dell’antica Akragas, ha coinvolto la platea composta da studenti, docenti e appassionati di filosofia con una lectio su “Gli antichi e noi”. Nel suo intervento ha tracciato un ampio excursus del pensiero greco – e non solo – evidenziandone l’attualità; e ha rivendicato come ineludibile la riaffermazione del pensiero critico come forma di confronto con il reale, lasciando intravedere invece i rischi – imminenti e concreti – di una sua eliminazione.
Cacciari in particolare ha lanciato un allarme rispetto a quella che ritiene una politica chiara in ambito europeo, cioè l’eliminazione della filosofia innanzitutto nel percorso di formazione scolastica in favore di quello che ha definito la “cultura del pasticcio”, cioè l’affrontare il tema del pensiero umano non dal punto di vista filosofico ma meramente biologico e sociologico. Chiaro anche il riferimento ad un pensiero fintamente efficiente, ma nei fatti snaturante, quale è quello dell’Intelligenza artificiale, che rischia di mettere a repentaglio l’esistenza stessa del pensiero filosofico. “L’intelligenza buona diventa in tal senso quindi solo quella artificiale – ha proseguito Cacciari –. O c’è quindi una reazione nel riaffermare il valore del pensiero filosofico o ci troveremo a parlare in futuro degli antichi solo in chiave archeologica e storica”.
“Il riferimento agli antichi – ha poi affermato durante le interviste Cacciari – ormai è qualcosa di puramente commemorativo, celebrativo. Perché in realtà tutta l’impostazione scolastica, formativa europea occidentale mira a far dimenticare gli interrogativi, le domande, le questioni davvero centrali che possono emergere dal pensiero classico. Il pensiero antico come l’abbiamo in mente noi ormai è qualcosa di, diciamo, turisticizzato. È una passeggiata nella Valle dei Templi senza avere la minima consapevolezza che in quel periodo vi erano le tragedie greche, vi era la filosofia eccetera. Se dimentichiamo tutto ciò, il nostro intelletto non è nient’altro che quell’organo che ci permette di misurare, calcolare, in modo efficiente, in modo utile, e lì ci arrestiamo, fine. E quindi chiudiamo ogni carattere trascendente del nostro esserci. Siamo lì. Ci addomestichiamo nella nostra finitezza, la consacriamo. Invece di vedere la nostra finitezza come anche una dimensione tragica del nostro esserci, la consacriamo e stiamo lì, tranquilli, sedati. E l’Antico è in tal senso un elemento che non fa altro che consolarci, che gratificarci, che permetterci una piacevole vacanza o la lettura di una bella poesia”.